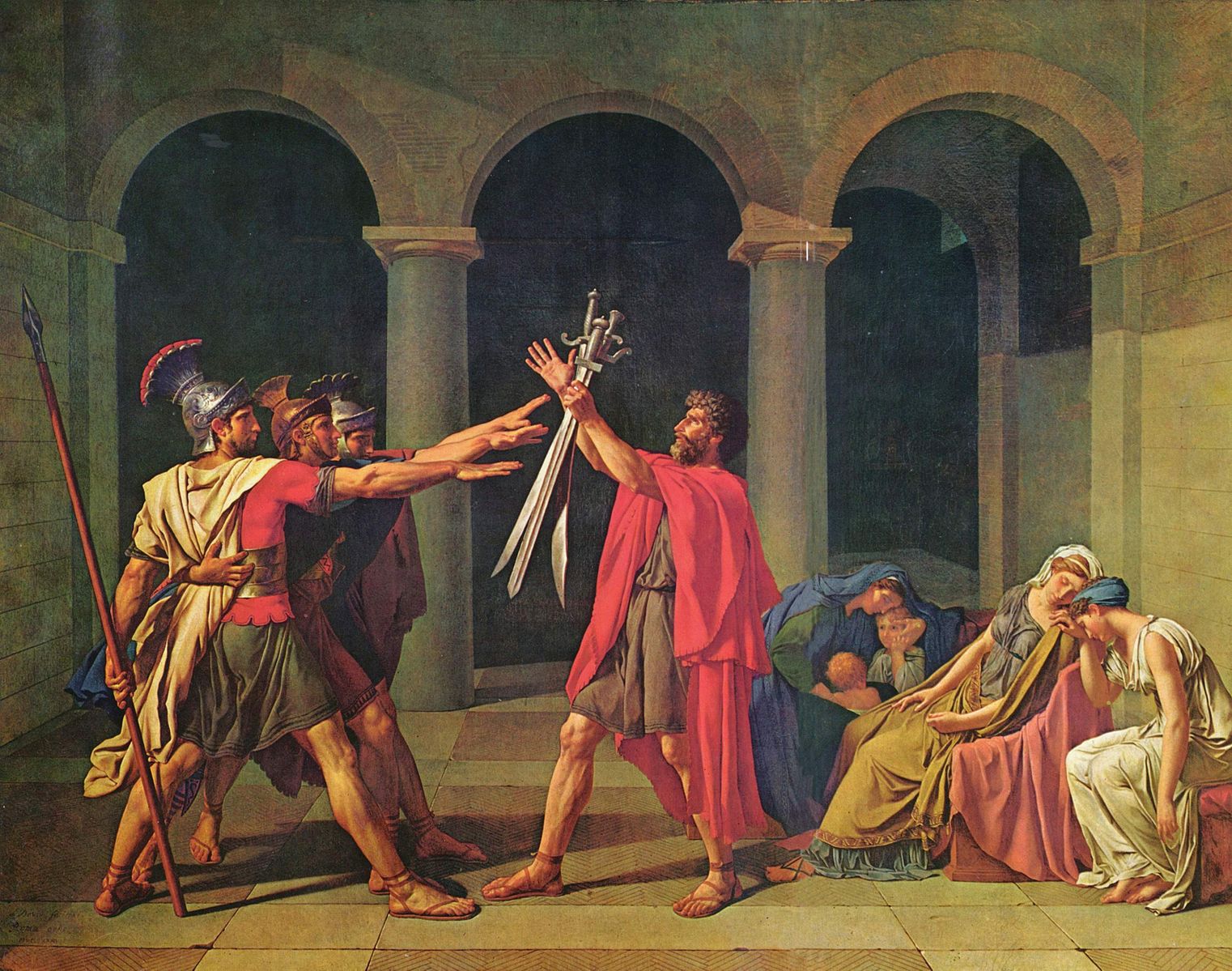Il seguente articolo è stato scritto traendo spunto dai preziosissimi suggerimenti della Dottoressa Chiara Iovacchini, dell’Università di Roma, La Sapienza, a cui va la mia sincera gratitudine.
Si tenterà di dare una risposta a tale quesito: è possibile discorrere di un diritto internazionale per gli antichi Romani?.
Spunto di questa riflessione è un interessantissimo articolo del Professore Francesco Sini, pubblicato nel 2003[1]. Come sottolinea il Professore, in apertura nel suo articolo, per rispondere al quesito posto occorre preliminarmente osservare che i Romani non erano in costante contrasto con le altre popolazioni e, al contrario, tendevano a instaurare dei rapporti, che allo stato attuale chiameremmo “relazioni internazionali”. È assolutamente errato pensare ad un c.d. “ostilità perpetua” con le popolazioni che vivevano ai confini di Roma.
Il principale sostenitore della c.d. ostilità perpetua fu per lungo tempo Mommsen, confutato, nel tempo, attraverso un’attenta rilettura delle fonti da Alfred Heuss, il quale pose ben in evidenza come Roma considerasse di vitale importanza il relazionarsi con gli altri popoli che vivevano ai suoi confini. In Italia, tali tesi vennero accolte da Francesco De Martino, nonché da Pierangelo Catalano.
Passando ora a considerare le caratteristiche proprie di Roma, in relazione alla guerra, si può constatare con certezza che Roma, dalle sue origini alla sua dissoluzione, fu caratterizzata dalla guerra e dalla fondamentale figura del dio Marte. Ecco, dunque, che nonostante la moltitudine dei collegi religiosi operanti e degni di considerazione a Roma, il Collegio dei Feziali godette di particolar rilevanza, fin dai tempi più remoti[2].
Gli autori latini, tra i quali si ricordano in particolare Pomponio, Ulpiano e Fiorentino, ponevano le origini del Collegio nell’età monarchica senza però che vi fosse certezza sul quale re lo avesse istituito[3].
Merita attenzione anche l’etimologia del nome del collegio. Il significato più antico e autentico del termine è da ricondurre alla fides pubblica, intesa come “pubblico affidamento”.
Per quanto attiene ai “poteri” attributi ai Feziali si annoverano, in primis, quelli inerenti alla dichiarazione della guerra, nonché considerazioni in merito ai trattati di pace conclusi da Roma con le altre popolazioni.
I Feziali erano un collegio presente anche presso altri popoli italici di stirpe latina. Essi non furono dunque un unicum del diritto romano, essendo presenti anche tra gli altri popoli italici preesistenti l’Antica Roma. Il Collegio era caratterizzato dall’ossequio per un insieme di leggi e regolamenti che dovette rappresentare un patrimonio condiviso tra tali popolazioni. Si può dunque sostenere, con le ovvie cautele del caso, che il diritto feziale era composto da un complesso di norme giuridico-religiose sovranazionali, quasi embrione di quello che diventerà nel tempo il diritto internazionale pubblico.
Nel corso della storia romana il Collegio non godette sempre della stessa importanza. Questo fenomeno emerse chiaramente, in tutte le sue manifestazioni durante il III a.C. con l’espansione mondiale di Roma. Nel ripercorrere le origini ed evoluzioni storiche del collegio potrebbe cogliere l’attenzione del lettore anche il fatto che Collegio venne richiamato in vita da Ottaviano Augusto al momento dello scontro finale con Antonio e Cleopatra nella battaglia di Azio del 31 a.C.
Volendo ora esaminare ancor più nello specifico il contenuto del c.d. ius fetiale, occorre precisare che esso riguardava diverse norme procedurali inerenti:
- La conclusione di trattati internazionali (foedera);
- Quelle relative alla deditio dei cittadini romani, riconosciuti colpevoli di aver violato trattati internazionali conclusi da Roma con altre nazioni;
- Alla dichiarazione di guerra.
I motivi per dichiarare guerra secondo lo ius fetiale erano legati alla violazione di una disposizione di un trattato. La procedura, in caso di violazione del trattato, prevedeva, in prima battuta, un tentativo di conciliazione con modalità pacifiche. Compito precipuo dei Feziali era proprio quello di presentare delle rivendicazioni, la c.d. rerum repetitio. Solo al seguito di tali negoziazioni la decisione di dichiarare guerra poteva essere discussa con i vari decisori politici, quali il Re, il Senato e l’Assemblea del popolo.
Volendo ora approfondire le procedure da rispettare per la dichiarazione di guerra, occorre preliminarmente osservare che il testo fondamentale per conoscere nel dettaglio il rituale in questione è di Tito Livio, nello specifico i passi 1.32-6.14 del suo celebre Ab Urbe condita. È importante sottolineare che le fonti in questione sono risalenti. L’adozione del diritto feziale rappresenta una tappa storica fondamentale per il diritto romano e la sua successiva evoluzione storica, politica, militare e territoriale.
Concetto fortemente annesso alle considerazioni sulla guerra è quello del c.d. bellum iustum. Nella concezione romana, per essere giusta la guerra doveva essere intrapresa nel rispetto delle regole morali, religiose e giuridiche, per ragioni difensive ovvero per sanzionare il mancato rispetto della parola data, il mancato rispetto delle clausole di un trattato internazionale, il c.d. foedus.
Leggendo attentamente le fonti virgiliane, poi, ci è possibile scorgere una considerazione particolarmente preziosa, purtroppo da non molti intuita: sul piano religioso- giuridico la guerra fu sempre concepita dai romani come rottura traumatica delle naturali relazioni pacifiche tra i popoli. Come affermava Francesco De Martino, abbisognava di una giustificazione, doveva trattarsi di un bellum iustum e cioè, come si vedrà, di una guerra condotta in modo ‘giusto’, ovvero conforme allo ius. L’uso immoderato della violenza rischiava di provocare l’ira degli dei. È proprio per tali ragioni che la guerra venne sempre più spesso attratta nella sfera del fas, vale a dire del diritto sacro. Le formule rituali dello ius fetiale e dello ius pontificium furono elaborate con la funzione di liberare i cittadini dalla paura del sangue versato e aiutarli con la religione a vincere l’antico terrore davanti al furor, segno di un possesso che priva l’uomo nella sua libertà, di esimersi dal timore di impegnarsi in azioni sgradite agli dei.
Anche la scansione del tempo fu impostata secondo feste cerimoniali religiose, legate all’inizio e alla fine di attività guerriere. Si spiegano in tal senso le ragioni dell’estrema cautela che circondava l’esercizio della guerra da parte dei singoli cittadini ai quali era consentito combattere solo in quanto milites. Curiosa correlazione a un’opera celeberrima, è particolarmente suggestivo il fatto che Virgilio faccia rilevare allo stesso Enea che l’esercizio della guerra si colloca nella sfera del nefas, in ragione dei suoi effetti devastanti di morte e contaminazione.
Tutte queste considerazioni giustificano la casistica rigorosa con cui i sacerdotes Fetiales e i teorici del diritto e della politica determinavano quali generi di guerre si potessero intraprendere legittimamente e cioè quali avessero le caratteristiche del bellum iustum. Le testimonianze antiche per quanto riguarda la definizione del bellum iustum, non sembrano quindi uniformate a principi di astratta morale ma attengono, come nel caso di Varrone, a valutazioni di conformità con la sfera religiosa e rituale dello ius fetiale. Secondo lo stesso Cicerone il bellum per poter essere dichiarato iustum necessitava di requisiti formali e sostanziali. I requisiti formali derivavano dalla osservanza dei riti e delle procedure dello ius fetiale, mentre i requisiti sostanziali dovevano consistere in motivazioni validamente determinabili, riconoscibili come tali in maniera oggettiva sia di fronte agli dèi che di fronte agli uomini.
Nell’approccio al diritto feziale, spesso si incorre nell’errore di confonderlo con lo ius gentium. In realtà è di vitale importanza mantenerli correttamente distinti.
Lo ius fetiale non era parte del più ampio ius gentium, in quanto la validità del complesso giuridico religioso feziale era indipendente da ogni riconoscimento o implicito consenso dei popoli stranieri[4]. Lo ius fetiale, doveva essere incluso, più nello specifico, nella branca del diritto pubblico romano.
Passando ad esaminare più nello specifico lo ius gentium, si colga che il termine presenta una polisemia. Un primo significato indica una comunanza di istituti giuridici tra più popoli presentandosi così in linea di continuità con il diritto feziale[5]. Il significato più diffuso di ius gentium, tuttavia, riguarda il rapporto tra i privati. Nello specifico, gli scambi commerciali a Roma avevano dato vita ad un insieme di relazioni giuridiche consuetudinarie con gli stranieri basati sulla fiducia reciproca tra le parti di cui troviamo una chiara traccia anche in due norme delle XII tavole. I rapporti privati con gli appartenenti ad altri popoli videro uno sviluppo intenso durante i primi decenni del III secolo a.C. In particolare, si segnala che nel 242 a.C. venne istituito uno specifico magistrato, il pretore peregrino, per esercitare la giurisdizione sulle controversie civili di cui almeno una parte era straniera. Molti di questi stranieri, a prescindere da eventuali trattati in vigore, giungevano a Roma per curare i propri affari e risultavano conseguentemente necessarie tutele giuridiche.
A cavallo tra il I e II sec. d.C. a Roma si iniziò a concepire l’idea, invero molto embrionale, di una comunità universale sovrastante i singoli popoli nazionali e nella quale confluivano tutti in funzione di un interesse comune e nei limiti da esso dipendenti.
Il diffondersi dell’idea dell’impero come entità universale, centro di rapporti internazionali ci permette di cogliere molte delle ragioni per cui Grossi abbia cercato nei testi del Corpus iuris civilis giustinianeo le soluzioni anche alle questioni giuridiche di carattere internazionale.
È bene evidenziare, giunti a tal punto del nostro esame, un confronto con il diritto internazionale moderno, nato, secondo dottrina maggioritaria, con la Pace di Westfalia (1648), al termine della guerra dei Trent’anni. Solo dopo di essa gli stati moderni prendono considerazione della loro eguaglianza sulla base di criteri di sovranità e liceità, superando, in modo definitivo, la visione universalistica medievale sul piano sia politico che religioso. Da questo momento in poi si viene progressivamente elaborando l’idea di un ordinamento giuridico internazionale e si avverte al tempo stesso l’esigenza di trovare una nuova giustificazione teorica di esso. Nei passaggi immediatamente precedenti si è avuto modo di osservare come tali considerazioni, sebbene solo in germe, fossero ben presenti anche tra gli antichi romani.
In aggiunta, terribilmente vicino al concetto di guerra giusta risultano le giustificazioni della guerra combattuta in Kosovo dove si è parlato della necessità di bloccare le operazioni di “pulizia etnica” praticate dal governo serbo contro la minoranza etnica e religiosa albanese. L’intervento è stato giustificato con la difesa dei diritti umani fondamentali e per questo definito “umanitario”. Sono state identificate in modo inequivocabile una serie di imperfezioni dell’intervento militare in questione, tra le quali la mancanza di norme internazionali legittimanti, la sproporzione tra fini e mezzi bellici, il significato di “guerra chirurgica” in relazione alla perdita di vite umane tra la popolazione civile. Il termine “giusto” è stato utilizzato per definire lo scontro quasi a voler indicare nella difesa dei diritti primari dell’uomo universalmente riconosciuti una necessità che travalica lo stesso principio di sovranità, attributo naturale degli stati. Si tratta di una motivazione che, sebbene non direttamente riconducibile alla classica teoria del bellum iustum, di stampo tomistico, la richiama molto da vicino[6].
Anche di recente si è tornati a parlare di guerra giusta in merito all’azione bellica in Afghanistan dopo i terribili attacchi terroristici dell’11 settembre 2001. Si notino le differenze con la concezione che i romani avevano di bellum giusto su indicata.
Nella concezione romana, poteva parlarsi di bellum iustum, nel momento in cui la guerra venisse intrapresa come contromisura a violazioni di specifiche disposizioni legislative e solo nel pedissequo ossequio di precisi procedimenti e rituali, strettamente attinenti alla sfera giuridico-religiosa. La violazione delle disposizioni di un trattato concluso da Roma, con un’altra nazionale, rientrava sotto la direzione del ius fetiale e dei sacerdoti feziali. Contravvenendo a tale procedura era impossibile discorrere di bellum iustum.
Emerge chiaramente da tali considerazioni, che nella sfera delle relazioni internazionali, per i romani, il concetto di bellum iustum, non appartiene al diritto internazionale, ius gentium, ma fa parte del diritto interno romano, componente della branca del diritto pubblico. Dal punto di vista romano, tutte le guerre di conquista condotte e che creavano nuove province romane, non erano guerre “giuste”. L’aggettivo iustum, nell’espressione, bellum iustum, non ha connotati etici, significando solamente che essa è conforme al ius, vale a dire, all’ordine giuridico romano. Era bastevole che la dichiarazione avvenisse nel rispetto di tutte le procedure previste dal diritto romano pubblico per assumere la denominazione di bellum iustum.
È tuttavia vero che nell’epoca moderna il diritto feziale romano ha costituito un modello, nonché una sorta di ispirazione per il diritto internazionale pubblico. L’affinità con il diritto feziale del diritto interazionale contemporaneo è stata messa in evidenza da frequenti riferimenti alla concezione di bellum iustum.
Sempre in tema risulta di particolare interesse la c.d. sponsio, o, se si preferisce, pattuizione internazionale. In origine è probabile che questa forma di accordo, conclusa direttamente fra comandanti militari all’esito di una battaglia, avesse gli stessi effetti di un trattato senza però osservarne il relativo procedimento. In seguito, la pattuizione tra comandanti degli eserciti in guerra ebbe un carattere provvisorio di tregua nonché una funzione preliminare di un successivo trattato, da realizzarsi secondo le modalità previste dal diritto internazionale.
Quel che deve qui colpire è l’adattamento di uno strumento di diritto privato a fini pubblici, per creare un impegno tra due popoli mediante la promessa assunta dai capi militari[7].
Per concludere, è fondamentale osservare che lo ius fetiale, sebbene a noi tanto lontano, continua a “vivere” nel diritto internazionale moderno, sebbene profondamente innovato e adattato alle complesse relazioni internazionali che caratterizzano la società attuale. Un diritto così intriso di ritualità ha posto le basi per quello che nel tempo è divenuto strumento indispensabili per regolare le relazioni internazionali attualmente esistenti.
[1] F. SINI, Sini – Guerra giusta e sistema giuridico religioso romano, in Diritto@storia 2, 2003.
[2] T. SAMBRIAN, Fetial law and bellum iustum in the context of the Daco-Roman wars and the Roman imperial policy of annexation of the provinces
[3] In dottrina, l’opinione comune è che l’origine dei feziali debba essere ricercata all’epoca antica di Roma sotto la dominazione di Latini e Sabini, più nello specifico, sotto la dominazione di Numa Pompilio, Tullio Ostilio e Anco Marzio (715-617 a.C. ca).
[4] P. CATALANO, Diritto e persone, I. Torino, G.Giappichelli Editore, 1990, p. 41.
[5] Tali caratteristiche sono evidenti in alcune testimonianze della storia di Livio dove il termine indica un diritto sovranazionale che viene violato con azioni belliche illegali.
[6] A. CALORE, “Guerra giusta” tra presente e passato, in Diritto@storia 2, 2003.
[7] Istituzioni di Gaio 3.94.